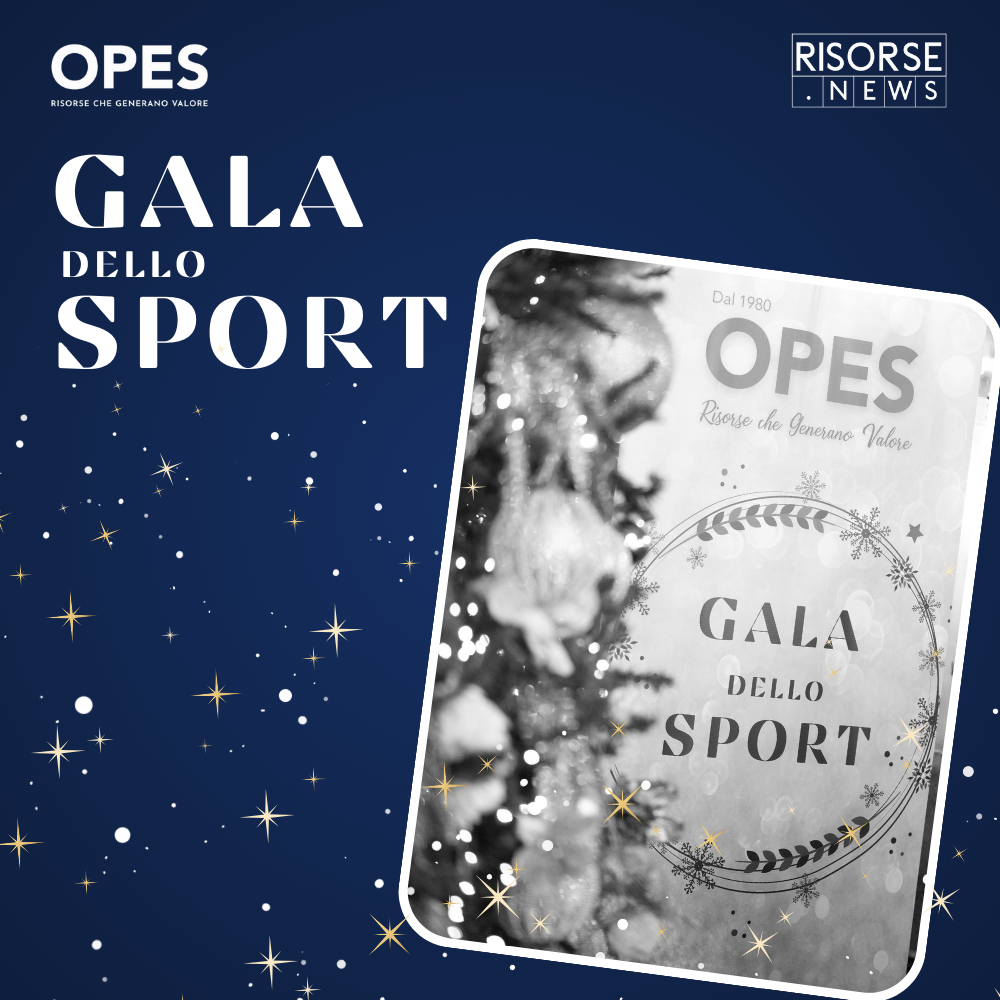La fotografia restituita dal “Rapporto Sussidiarietà e… welfare territoriale 2023/2024”, realizzato da Fondazione Sussidiarietà, in collaborazione con il centro di ricerca Aiccon, IFel (Fondazione ANCI), Ipsos e Istat, mette a punto un quadro tutt’altro che positivo per il sistema Italia. Non ci si poteva aspettare che la situazione fosse diversa, considerando il contesto internazionale e la gestione delle risorse in relazione ai tempi. Si parte dal presupposto che negli ultimi tre anni il 70% degli italiani ha avuto difficoltà ad accedere a servizi fondamentali di welfare.
L’indagine, raccontata in trecento pagine, individua quali sono le complessità, i bisogni, i limiti e la risposta territoriale e nazionale in materia di welfare. Sono diversi gli esempi che trovano contrapposizioni interessanti; uno è rappresentato dall’utilizzo delle nuove tecnologie.
Se la digitalizzazione dei servizi va al passo con i tempi e in qualche modo innova il lavoro, mette anche tutti coloro, e ne sono più di quanti ci si aspetti, che non solo hanno dimestichezza con le avanguardie digitali a non poter accedere anche ai servizi più banali. Il Rapporto, infatti, prende i call center a modello: gli operatori digitali mettono in crisi i fruitori; venendo meno il fattore umano e dunque la possibilità di spiegare dettagliatamente una situazione che, nella fattispecie, risulta soggettiva, la persona si trova spiazzata, senza punti di riferimento e magari rinuncia o dilata i tempi alla risoluzione di un problema x.
Queste situazioni sono emblematiche e sono anche lo specchio di come, nonostante gli enormi progressi, larga parte della popolazione italiana non abbia i mezzi per adattare le proprie conoscenze a quelle nuove richieste. In ogni ambito. Una rappresentazione, scandagliando quindi le riflessioni del Rapporto, relativa al gap nel dialogo tra i bisogni del Paese reale e le proposte messe in campo dalle istituzioni (nazionali e internazionali), gli enti locali e così via.
Più in generale, comunque, il documento asserisce problematiche complessissime che devono trovare risoluzione in tempi brevi. Infatti, nell’introduzione si spiega chiaramente che, seppure l’Italia abbia la spesa sociale in rapporto al PIL tra le più alte in Europa, aumenta di netto il numero sulla povertà assoluta (5,7 milioni gli individui che vivono questa condizione, oltre un quarto delle famiglie con persone con disabilità rientra in questo numero), alle pensioni di anzianità e vecchiaia sono destinati due terzi della spesa sociale e la scuola, o più in generale il mondo dell’istruzione riceve solo il 4% del PIL.
Un ultimo riferimento è a tutte le persone che invece non hanno un’occupazione e per il cui supporto, in termini di welfare, non si moderano le disuguaglianze.
Possibili, invece, le crescite di alcuni ambiti welfare come quello aziendale che potrebbe rappresentare uno strumento utilissimo per il futuro. Così come cresce il credito verso il Terzo settore: “Le associazioni non profit – si legge nel paragrafo dedicato – vengono viste come un elemento che fa la differenza, specie nei territori dove il welfare pubblico è più carente”.
Basti pensare che delle 85.574 strutture che si occupano di welfare in Italia, il 68,8% è attribuito alle non-profit, mentre il 31,2% alle istituzioni pubbliche. Va però sottolineato che, negli ultimi tre anni, il Governo ha incrementato le sinergie con le realtà simbolo del Terzo settore, istituendo tavoli di lavoro e favorendo dialoghi costanti tra il Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega al Terzo settore, Maria Teresa Bellucci, e rappresentati degli Enti.
Il Rapporto in pillole
L’edizione numero 18 del Rapporto, dunque, va a strutturare “la genesi e la natura dei sistemi di protezione sociale e offre una panoramica sui fattori che spingono i sistemi di welfare verso il cambiamento”, per citare le penne che hanno aderito all’iniziativa.
Nel primo capitolo, curato da Campiglio, viene offerta una panoramica, anche sul passato, del welfare definito come “esito del passaggio dallo Stato minimo allo Stato sociale”; significa perciò capire cosa ha animato il dialogo fitto e fruttuoso tra i Paesi occidentali per ottenere una rete di welfare efficace e duratura nel tempo, e cosa invece adesso stia portando al declino di questo sistema che per anni ha funzionato, in altre parole quella che Campiglio definisce una “tolleranza fiscale” operosa.
Andando avanti, nelle pagine redatte da Pratesi e Solipaca, si entra nel merito della spesa fino al 2022, considerando che la questione economica nazionale e internazionale è un tema centralissimo. Gli autori restituiscono in tal senso una riflessione importante: “per le funzioni destinate alla famiglia e alle cure sanitarie l’Italia occupa l’ultima e la penultima posizione in Europa, mentre molto bassa è anche l’allocazione delle risorse per l’assistenza alle persone con disabilità”. In pratica, gli ambiti in cui si avrebbe più bisogno di investire.
Altresì, in questa parte di testo, si avanza un’altra considerazione, che riguarda il modello welfare del Bel Paese. Infatti, l’indicazione è che tale modello si basa su trasferimenti economici, anziché sull’erogazione di servizi alla persona. Contrariamente, ad esempio, alla Svezia che va a distribuire più risorse proprio ai servizi in quanto tali e guarda meno alla parte economica.
Nel terzo capitolo, invece, si analizzano i trend demografici che denotano famiglie sempre meno numerose e un numero enorme di anziani a rischio isolamento; sono infatti 9 milioni le persone appartenenti a questa categoria. Va da sé che sussiste un problema enorme anche in relazione al fenomeno di denatalità e di crescita del divario tra persona anziane e nuovi nati. Comunque gli autori, in prima battuta, si pongono il problema dei servizi socio-sanitari; vale a dire i servizi in quanto tale, l’accesso a tutto ciò che può essere utile per i fruitori e la facilitazione verso attività attinenti.
Welfare privato
Procedendo nella lettura, Santoni e Impellizzieri riferiscono di un “trend in rapida ascesa: quello della spesa privata per il welfare (una spesa che nel 2022 ha raggiunto il 20% del totale). Un tema attualissimo, soprattutto se si riflette sulla società che cambia. Dal 2020, dall’isolamento forzato, si è attivato un meccanismo che ha messo le persone, di ogni età ed estrazione sociale, di fronte a una nuova verità: la necessità di avere un nuovo work-life-balance. Vale a dire, la possibilità di avere una vita privata piena, che non sia soggetta ai tempi dettati dall’impegno lavorativo.
Probabilmente il fenomeno che ha avuto maggiore risonanza in tal senso è quello delle Grandi Dimissioni; da quel momento c’è stata un’escalation che ha messo anche le aziende nella condizione di riflettere più attentamente sulle nuove necessità dei dipendenti.
Il Rapporto, comunque, riferisce che, visti i punti affrontati, “i bisogni di welfare legati alla conciliazione vita-lavoro, alla cura e all’assistenza sono un costo sempre più imponente per le famiglie italiane”. Gli autori del quarto capitolo chiamano in causa il rapporto Cerved del 2022 – intitolato Bilancio di welfare delle famiglie italiane 2022 – secondo cui la “spesa di welfare non pubblica è circa il 20% del totale ed è stimabile intorno ai 157 miliardi annui.
Per la quasi totalità è a carico delle famiglie (circa il 17,4%), ma si espande il contributo del welfare aziendale (le iniziative delle singole imprese) e collettivo (la raccolta dei fondi previdenziali e sanitari), pari al 2,7%”.
Nel 2021, si osserva, che le famiglie italiane hanno speso mediamente 5.317 euro per le prestazioni di welfare. La spesa complessiva è stata circa 136 miliardi di euro, pari al 17,5% del reddito familiare netto e il 7,8% della ricchezza nazionale. Andrebbe sommato a questo dato anche quello dei 21,2 miliardi di welfare aziendale e collettivo. Resta comunque un numero su cui sarà necessario riflettere nei tempi a venire: la voce più alta di spesa per le famiglie italiane è riferita alla salute, ben 38,8 miliardi di euro. Seguono poi: assistenza agli anziani e altri familiari disabili o non autosufficienti, che si traduce in 29,4 miliardi.
Nelle conclusioni si adduce che il “welfare aziendale può divenire uno strumento di sviluppo locale in grado di rispondere coerentemente ai bisogni di imprese, lavoratori e lavoratrici. Sviluppate in una concezione territoriale, le iniziative di welfare aziendale possono divenire maggiormente inclusive”.
“In questa direzione – proseguono gli autori – il welfare aziendale territoriale riesce a produrre innovazione sociale grazie alla presenza di reti multi-attore e multi-stakeholder e, quindi, di una governance complessa che cerca di mettere in relazione i soggetti che all’interno del territorio si occupano del welfare”. Va comunque chiarito che gli esempi virtuosi o comunque le realtà che applicano tali principi sono ancora poche.
Il welfare territoriale
Il capitolo 5, a cura di Fondazione Ifel e REF Ricerche, invece intende tracciare un altro tipo di percorso che riguarda il welfare locale “sulla base di un aggregato di spesa nazionale relativo alla protezione sociale, che include anche la spesa pensionistica e che coinvolge i diversi livelli di governo”.
In questo caso, sono stati analizzati dati che vanno dal 2001 al 2022 e che mettono in evidenza la crescita costante della spesa nazionale. Nel 2022 questa cifra si traduceva in oltre 114 miliardi. Un fattore interessante riguarda l’incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale (legge di bilancio 2021) che aveva l’obiettivo di agire sui servizi alla prima infanzia e ai servizi sociali.
Un’evoluzione, quella della spesa sociale dei Comuni, che viene definita storica, in particolare riferimento agli anni 2000.
Terzo Settore e welfare del futuro
Un ambito che registra una crescita assolutamente da considerare è quello del Terzo settore. “I dati mostrano – si spiega nel Rapporto – come vi sia un ampio consenso, soprattutto tra le fasce più anziane e istruite della popolazione, sul ruolo cruciale che il Terzo settore svolge e sarà sempre più chiamato a svolgere nelle politiche sociali. Ben il 70% concorda sul fatto che il peso di questo settore è destinato ad aumentare, percentuale che sale al 77% tra gli over 65”.
Ancora in numeri, il Terzo pilastro vanta un consenso del 66% se si risponde alla domanda quanto il TS stia sopperendo alle lacune lasciate dallo Stato. Si evidenzia pertanto la capacità del Terzo settore di raggiungere le persone fragili, o quanto meno quelle fasce che hanno un maggiore bisogno di supporto. Il non-profit riesce quindi a rispondere alla domanda di welfare territoriale più di quanto ci si aspetti. Dal 2016 le istituzioni non-profit sono cresciute del 5,3% con un incremento delle persone impegnate nel settore dell’11,3%.
Tirando le somme, per il futuro sembrerebbe sempre più plausibile prevedere di “ancorare il finanziamento del welfare alla fiscalità generale, cioè alle imposte pagate da tutti i contribuenti in base al proprio reddito. Questa opzione registra un punteggio medio di 3,5 su 5 e raccoglie il favore della maggioranza assoluta (63%) degli over 65, tradizionalmente i più fedeli al modello universalistico. Percentuali superiori alla media si registrano anche tra gli uomini (52%), i residenti nelle grandi città (53%), i laureati (52%) e i non occupati (54%)”.
SCARICA QUI IL RAPPORTO COMPLETO